Dizionario etimologico dei dialetti della Val Tartano
|
di Giovanni Bianchini e Remo Bracchi Sondrio, IDEVV – Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca, 2003. |
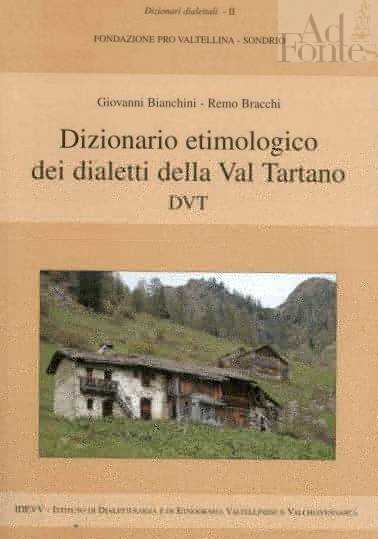 |
Vi par possibile che una persona che risiede a Morbegno da quasi trent’anni, che ama fare lunghe camminate, non abbia mai trovato il tempo o la voglia di vedere la Val Tartano? Lo confesso subito: non ho mai visitato, percorso o visto la Val Tartano, una valle pur tanto vicina al luogo dove vivo. Ma, nonostante questa colpa, la Val Tartano mi pare di conoscerla ugualmente. L’ho incontrata per anni viva nel diario scritto dal parroco di lassù nel corso dei primi decenni del Novecento, pubblicato, a puntate, sul bollettino Comunità Valtartano. L’ho ritrovata negli opuscoli, nei libri e negli articoli che, di tanto in tanto, sono comparsi sulla stampa locale. E poi, in tutti questi anni, mi è capitata la fortuna di conoscere alcune persone ricche di umanità e di profonda cultura (per tutte Giulio Spini e Evaristo Bianchini), originarie proprio di lì. Certo, sono d’accordo con chi mi volesse ugualmente rimproverare la mancata conoscenza diretta di una delle zone più interessanti della Bassa Valtellina. Ma forse, almeno in parte, verrò perdonato dai miei due lettori quando (poveretti!) avranno gustato per intero questo articoletto. Parlo di due, e mi sembra una giusta proporzione nei confronti del nostro grande Alessandro Manzoni che si era spinto ironicamente a immaginarne venticinque per i suoi Promessi Sposi («i miei venticinque lettori» scrive nel primo capitolo del romanzo, subito dopo l’incontro di don Abbondio con i terribili bravi).
È vero, non ho mai messo piede in Val Tartano. Però, come anticipato nelle prime battute di questo articolo, ho letto regolarmente pagine e pagine dedicate a questa valle tanto vicina e, per me, almeno per ora, remota.
Ed è proprio un’opera sulla Val Tartano che fa da apripista alla schiera dei ‘magnifici quindici’. Vorrei allontanare subito un possibile equivoco. Il libro presentato per primo non è il primo di una classifica. I quindici libri che suggerirò li considero tutti sullo stesso piano, tutti altrettanto preziosi. Ma partiamo subito dal primo.
Il Dizionario etimologico dei dialetti della Val Tartano, di Giovanni Bianchini e Remo Bracchi (pubblicato dall’IDEVV, Istituto di dialettologia e di etnografia valtellinese e valchiavennasca, nel 2003). Qualcuno, forse, si sarebbe aspettato –come proposta d’inizio– un autorevole libro di storia oppure un bel volume sull’arte locale. Invece, eccoci di fronte a un’opera di tutt’altro genere, che, almeno a prima vista, parrebbe destinata a interessare esclusivamente gli addetti ai lavori, i dialettologi e gli studiosi di etnografia. In questo caso l’apparenza inganna. Basta aprirlo e … voilà: dalle quasi 1.700 pagine che costituiscono uno scrignetto prezioso appare un magnifico affresco che raffigura fin nei minimi dettagli l’immagine di un mondo e di una cultura contadini, descritti appena in tempo, prima che su di loro scenda il buio. Un piccolo mondo antico che viene offerto all’interesse di tutti, anche di chi non è mai vissuto ‘da quelle parti’.
Dizionario etimologico. Il titolo, sintetico e riduttivo, è di quelli che potrebbero trarre in inganno. Contiene, senza dubbio, un lungo elenco di parole dialettali, presentate in ordine alfabetico e ‘raccontate’ da Giovanni Bianchini, parole di cui Remo Bracchi indaga l’etimologia, cioè l’origine e la storia. Ma questa raccolta è tanto più preziosa quanto più permette a un piccolo rettangolo di vita vissuta di lasciare una traccia profonda nel tempo. Oggi siamo convinti che il dialetto rappresenti uno dei pilastri della nostra identità, ma se non procediamo in fretta –ed è già tardi– a indagarne e raccoglierne le tracce, rischiamo di lasciar precipitare nell’oblio le opere e i giorni di un’intera cultura. Intanto, per avere anche solo una piccola idea della ricchezza contenuta in questo volumone, occorre armarsi di un poco di pazienza e di tanta sana curiosità. Tra quella mole di pagine stampate risalta nitida l’immagine della cultura contadina di un tempo. Come si viveva, come si pensava, a cosa si credeva. In Val Tartano, certo; ma i ritmi dell’esistenza in tutti i nostri paesini di montagna non erano poi tanto diversi. Giovanni Bianchini, comunque, non sovrappone larghe pennellate color di rosa sull’affresco che racconta il tempo che fu della sua Val Tartano, anzi fa di tutto per evitare di trasmetterci una visione edulcorata di quel mondo scomparso. Mondo da ricordare, non da rimpiangere: troppa miseria, troppe ingiustizie. Come avveniva nei libri antichi, anche questo inizia con una dedica: un pensiero delicato rivolto alla memoria dei genitori (Virginia e Luigi) e della zia Savina. Ma, anche se alla base di tutto questo lavoro c’è un profondo atto d’amore per il proprio paese, Giovanni Bianchini avverte subito –quasi con durezza (quella che si ritrova qua e là, quando graffia il potere costituito)– che non si tratta di un’operazione condotta sulle tracce di una dolce nostalgia. È chiara, fin dalla dedica iniziale, la sua visione di questo mondo passato: nel ricordo della nostra gente che ha vissuto di fatiche e di stenti su questa aspra terra avara. E lui è consapevole di fornire una testimonianza di storia. Il documento indispensabile di una cultura e di un modo di vivere di cui presto resterà soltanto una traccia leggera, l’ombra di un ricordo. Ma proviamo ad addentraci nella foresta del dizionario per ritrovare quel mondo lontano. Basteranno questi pochi esempi (e se ne potrebbero ricavare centinaia) per comprendere che non stiamo sfogliando un semplice elenco di parole.
Ecco le prime quattro pennellate, legate in qualche modo alla religiosità popolare:
laurà per la gésa …
ha il significato di lavorare senza compenso,
senza utilità personale … era normale un
tempo svolgere lavori di manovalanza (portare sassi,
legni, sabbia, calcina, ecc.) gratuitamente quando si costruiva o si
riattava una chiesa o la canonica. Le numerose chiese costruite in
Valtellina, soprattutto nella controriforma e successivamente, ancora
per riflesso di questa, comportavano sacrifici gravosi in prestazioni
gratuite di lavoro e in denaro alle nostre popolazioni.
La chiesa, che era rigidissima nel far rispettare il riposo festivo,
sollecitava il lavoro nei giorni di festa per la costruzione di chiese
o per costruzioni o ristrutturazioni di stabili della parrocchia,
svolgendo il quale si acquistavano pure meriti per l’aldilà.
curùna = corona del rosario. Si recitava la corona del rosario … tutte le sere dopo cena nella famiglia riunita, con l’aggiunta di invocazione ai santi, più spesso patroni di paesi vicini, e di altre preghiere, specialmente per i defunti. La recita del rosario alla sera era un obbligo a cui le famiglie adempivano con scrupolo; anche durante i lavori della campagna, quando tutti erano molto stanchi, la corona non poteva essere tralasciata: chi cascava dal sonno veniva tenuto sveglio.
Qualche volta, accanto alla definizione di un vocabolo, troviamo un ritratto
sbalzato a tutto tondo (manca soltanto un nome e un cognome). Qui un mestiere
scomparso viene reso vivo da una figura che l’ha esercitato.
Ad esempio, dopo curùna c’è curunàt.
curunàt = coronaio. Era un artigiano di Campo
che, fabbricava corone del rosario, Essendo zoppo, quindi
impossibilitato a svolgere i lavori nella campagna, e per
di più cieco da un occhio, era stato stimolato dal
parroco ad esercitare questa attività artigianale.
Il parroco era egli stesso capace di fabbricare corone del
rosario. Il mestiere esigeva solo l’uso di una pinzetta:
svolgeva il lavoro con grande sveltezza, tenendo con le mani
il suo piccolo attrezzo e il materiale vicino all’occhio
sano. Vendeva corolle anche a conventi e istituzioni religiose
in diverse città italiane. E si manteneva con il suo lavoro.
dà fò la saal = distribuire il sale: si riferisce
all’usanza di distribuire sale ai partecipanti alle funzioni di
suffragio nell’ottavo giorno dopo la morte di qualcuno:
veniva distribuito come beneficenza in suffragio dell’anima
del defunto, a una persona per ogni famiglia circa un
chilo di sale. Non tutti potevano permettersi questa spesa,
solo famiglie buni, che avevano un certo patrimonio,
costituito principalmente da parecchie mucche.
Bisogna tenere inoltre presente che il sale ora considerato
assai prezioso e veniva economizzato per quanto possibile,
perché i soldi per acquistarlo erano, in generale,
scarsi o spesso mancavano. Ancora nella seconda metà
del secolo scorso, c’erano famiglie che
mettevano il sale nella polenta solo alla festa.
Giovanni Bianchini non dimentica i pochi momenti di festa,
ma avverte che anche quelli venivano attenuati, quando non soffocati, da un rigido controllo sociale
nòz = pranzo di nozze. Il pranzo di nozze,
più o meno abbondante in rapporto alla condizione
economica, era fatto nella casa dello sposo; parte degli
invitati, data la ristrettezza degli spazi disponibili,
venivano spesso ospitati in case vicine. Per cucinare ci
si arrangiava, magari chiamando qualcuno che passava per
esperto e che si prestava volentieri in queste occasioni.
Il piatto fondamentale era costituito dal risotto, seguito da
salumi di casa e formaggio (alle volte, se la famiglia
caricava un alpeggio, era tagliata uno forma di formaggio
tipo Bitto stagionata, conservata magari da alcuni anni
in vista dell’evento), o anche da carne, specialmente di capra.
Si acquistava una baga (otre di pelle) di vino. Le
stoviglie di terracotta erano molto rare e, si usavano
scodelle e cucchiai di legno: il vino veniva bevuto, di
solito, dal ciapèl (scodella dì legno). Si prestavano
da famiglie vicine le stoviglie che mancavano: in tempi più
recenti si prestavano dalle osterie piatti, forchette e anche
bicchieri. A ogni famiglia della contrada veniva offerta una scodella
di risotto. Si cantava e, alla volte, c’era chi suonava
una fisarmonica; non si parlava di ballo. Spessa alla
sera coronava la festa una taragna.
bal = il ballo, la danza. In Valle non si ballava mai,
perché il ballo era ritenuto un divertimento estremamente
peccaminoso. Qualche raro giovane, che aveva imparato a ballare sotto
la naia o come emigrante all’estero, il quale si permetteva di ballare
alle volte nei paesi vicini era considerato un poco di buono.
Se capitava rarissimamente che, in una veglia quando c’era una
fisarmonica, delle coppie dì giovani si mettevano con circospezione
a ballare, succedeva lo scandalo: la gente deplorava quell’audacia e
il parroco, magari, non mancava di fare qualche allusione dal pulpito alla
corruzione che stava entrando nella parrocchia.
E in altre due registrazioni ritroviamo un eccezionale spaccato di cultura popolare:
lüna = la luna. le fasi lunari. Un tempo si prestava una
particolare attenzione alle fasi lunari, come –in genere– ai fenomeni
atmosferici. Era comune la convinzione che la legna tagliata nei primi
tre giorni della luna essiccasse più presto di quella tagliata
in altri giorni e quindi bruciasse meglio: il taglio di boschi veniva
effettuato nella luna di marzo, perché il legname tagliato in
tale mese si conserva e non si screpola; il legname nella luna d’agosto
produce un verme sotto la corteccia (el fa la càmula).
La verdura che cresce sopra la terra (lattuga, cicoria, prezzemolo, ecc.)
si seminava in luna crescente, mentre ciò che cresce sotto terra
(patate, carote, cipolle, ecc.), veniva seminato in calo di luna. Il tempo
più adatto per spargere il letame nei prati si credeva fosse
nella luna crescente, poiché si diceva che il letame penetrava meglio nel terreno.
stüdi = lo studio, gli studi. C’era differenza nei
riguardi degli studi, anche se gli intellettuali (i medici, gli
avvocati, i notai) erano tenuti in grande considerazione e circondati
di deferenza e di rispetto. I preti scoraggiavano, in genere, qualche
famiglia che eventualmente –su suggerimento della maestra– avrebbe
potuto far studiare un figliolo o una figliola, perché dicevano
che era meglio non introdurre novità nella famiglia e anche che
lo studio è un’arma a doppio taglio, che può anche traviare
sul piano della fede e della morale. In effetti si può dire
che nella Valle nessuno studiava, salvo i ragazzi che frequentavano il
seminario o qualche raro maestro o qualche levatrice.
Ebbene, credo proprio che questi esempi possano bastare per stuzzicare la curiosità e spingere a una lettura accurata di questo primo libro salvato per la nostra biblioteca di cultura locale. Ho pensato, tuttavia, che a questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: «Questo dizionario sarà pur bello e interessante, però riguarda esclusivamente ‘quelli della Val Tartano’». Ora, se le dimostrazioni precedenti non vi hanno ancora convinto del valore generale dell’opera –un lavoro dove, tra le parole, si mescolano e si sovrappongono la storia religiosa con la storia culturale, la storia economica con la storia sociale– è necessario compiere uno sforzo ulteriore, andando ad attingere al contributo particolare del secondo autore, Remo Bracchi, sacerdote e studioso, oggi indiscusso principe di coloro che si dedicano alla dialettologia in provincia di Sondrio. Ed è lui che ci conduce con mano ferma e sicura, in modo convincente, attraverso il vasto campo minato delle etimologie. I suoi studi ci conducono alla scoperta delle radici di tutte le parole, sia le parole comuni che quelle dei nomi di luogo (i toponimi). Un campo minato perché soprattutto le etimologie dei nomi di luogo hanno prodotto e producono ancora di tanto in tanto scoppi mortali di sciocchezze e stupidaggini. È vero, non è facile individuare l’origine di un vocabolo. Spesso una parola, nel corso della sua lunga vita, ha cambiato il suo vestito, modificando sostanzialmente l’aspetto esteriore (chi riuscirebbe di primo acchito a leggere la stessa radice di ‘lago’ nei toponimi di Colico, Samolaco, Lecco, Bellagio e Bellano?). Soltanto chi studia a fondo la storia della lingua può riuscire, quando ci riesce, a togliere il velo che ricopre la radice e l’anima di una parola. Quante volte, ad esempio, ci chiediamo quale possa essere l’origine del nome di Morbegno. Ebbene, Remo Bracchi dedica ben 35 righe e un serio e convincente percorso alla ricerca delle vere radici, partendo dall’ipotesi che derivi dal latino ‘morbidus’ terra grassa, produttiva escludendo subito la derivazione da morbo, malattia. Non manca anche un accenno a Talamona, che sembrerebbe derivare dalla radice gallica ‘talamon’ che significa semplicemente terra. In quanto a Chiavenna, per troppo tempo e troppo superficialmente spacciata come ‘chiave per i valichi alpini’, l’unica ipotesi plausibile è considerata la radice antichissima, prelatina, ‘clava’ (ammasso di detriti di sfaldamento, cono di deiezione). Non parliamo poi del toponimo Cèk, cui Bracchi dedica quasi un piccolo trattato, con abbondanza di spiegazioni scientifiche. E anche tutto questo si trova tra le pagine del Dizionario etimologico dei dialetti della Val Tartano.
Ma dobbiamo concludere.
E mi piace farlo con qualcosa di personale.
Ricordo che un giorno, più o meno dieci anni fa, nel 1994 o nel 1995, Giovanni Bianchini
mi disse che avrebbe gradito una mia recensione del suo libro, allora fresco di stampa, il Vocabolario dei dialetti della Val Tartano.
Era la prima edizione, già bellissima, ma priva dell’apparato etimologico curato da Remo Bracchi.
Allora, ancor più di oggi, mi sentivo inadeguato a indossare le vesti del recensore, per di più
nei confronti di un simile lavoro scientifico.
Ma lui aveva letto una mia libera considerazione, pubblicata sul Gazetìn di Morbegno,
riguardante un saggio letterario scritto da Gabriella Rovagnati, un libro stupendo che descriveva il
mondo della letteratura viennese a cavallo tra Ottocento e Novecento.
E, visto che questo mio articoletto non gli era dispiaciuto, mi chiedeva di scriverne uno sul vocabolario che lui
aveva appena pubblicato.
Quell’articolo–recensione però non l’ho mai scritto.
La mia pigrizia, quando si tratta di scrivere, aveva vinto la sua ennesima battaglia.
Mai come in questo caso però posso esclamare: felix culpa!
Infatti, se la prima edizione del volume sui dialetti della Val Tartano era un gran bel lavoro,
la seconda edizione, quella di cui abbiamo parlato in questo articolo, è un lavoro eccezionale.
A scanso di equivoci: d’ora in poi qualsiasi dizionario dialettale valtellinese non potrà fare a meno
di confrontarsi con quest’opera.
Fino a pochi anni fa incontravo Giovanni Bianchini, di solito per caso, nella sala d’aspetto della stazione di Morbegno. Altre volte, invece, veniva a trovarmi alla biblioteca Vanoni. Si chiacchierava di tante cose ma si parlava per lo più di libri e di cultura locale. Non erano incontri regolari e frequenti, ma mi bastavano per riascoltarlo sempre con piacere. Giovanni Bianchini rappresenta per me una di quelle persone di grande e profonda cultura che ho avuto la fortuna di conoscere in questi trent’anni di attività bibliotecaria. Mi ha fatto capire una volta di più che la cultura va coltivata e vissuta ogni giorno e, soprattutto, va condivisa sempre con gli altri, con chi abbiamo vicino. Oltre a voler cambiare il mondo, impresa spesso velleitaria e non sempre facile da realizzare, «il faut cultiver notre jardin» (dobbiamo coltivare il nostro giardino), aveva già suggerito Voltaire, alla conclusione del viaggio del suo Candide.
Renzo Fallati



